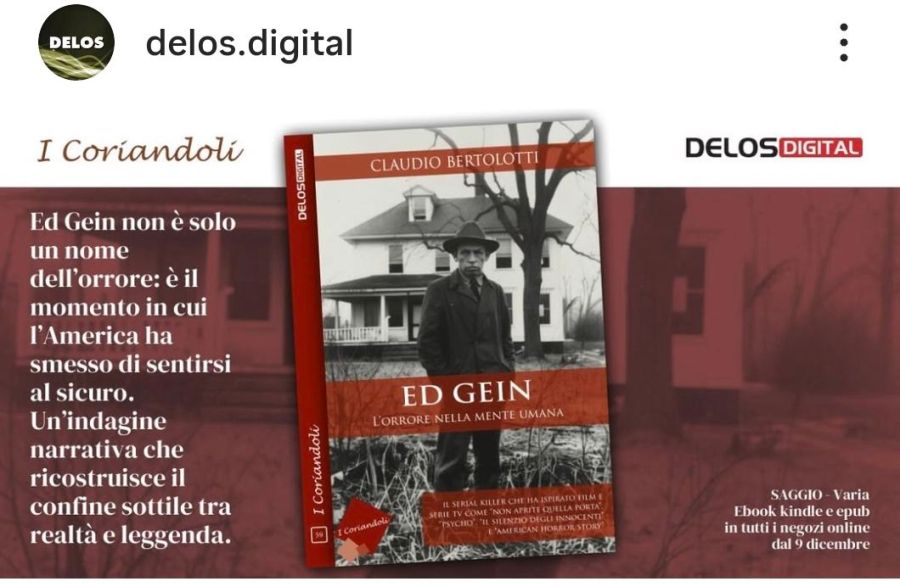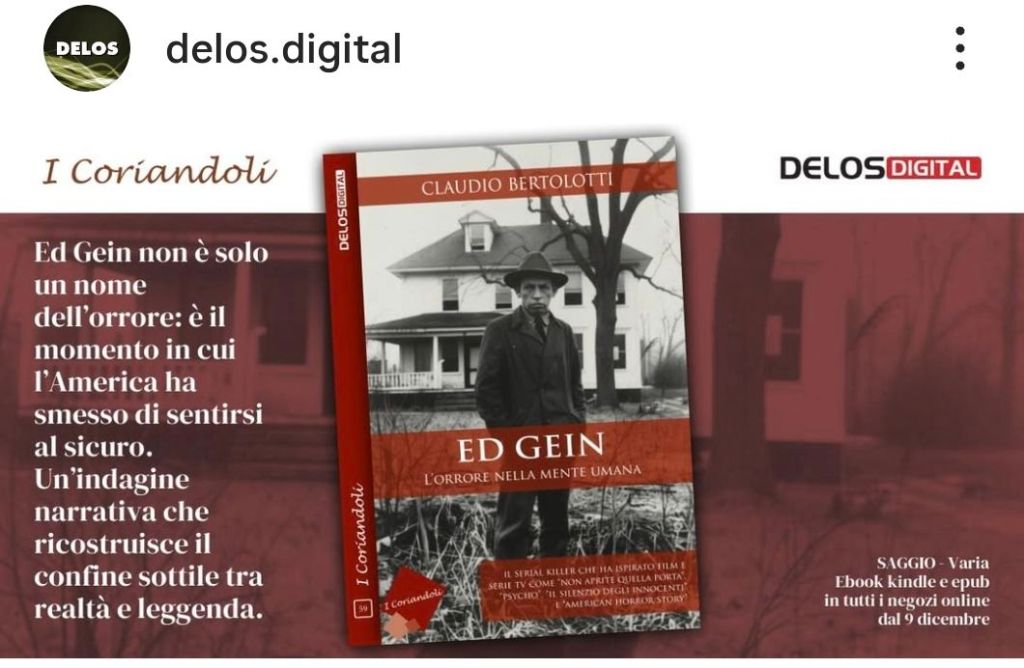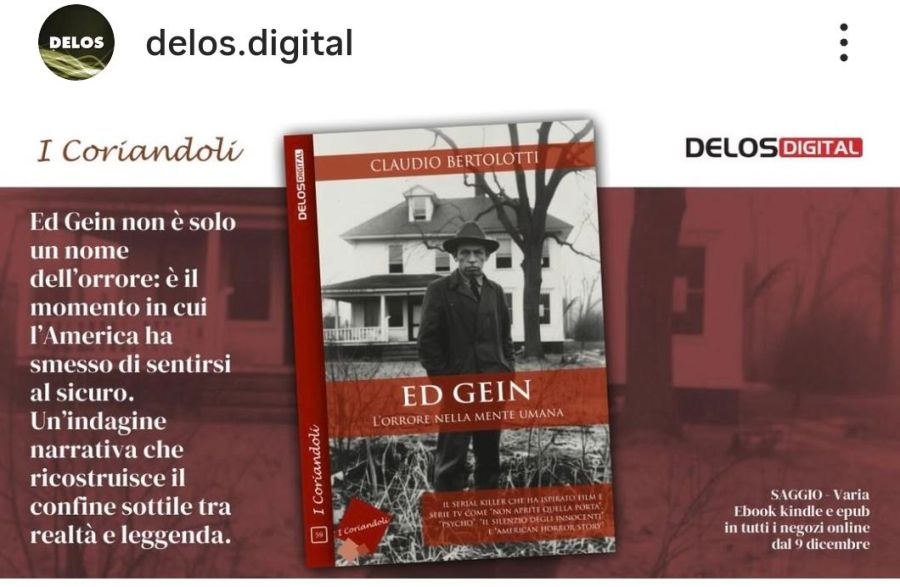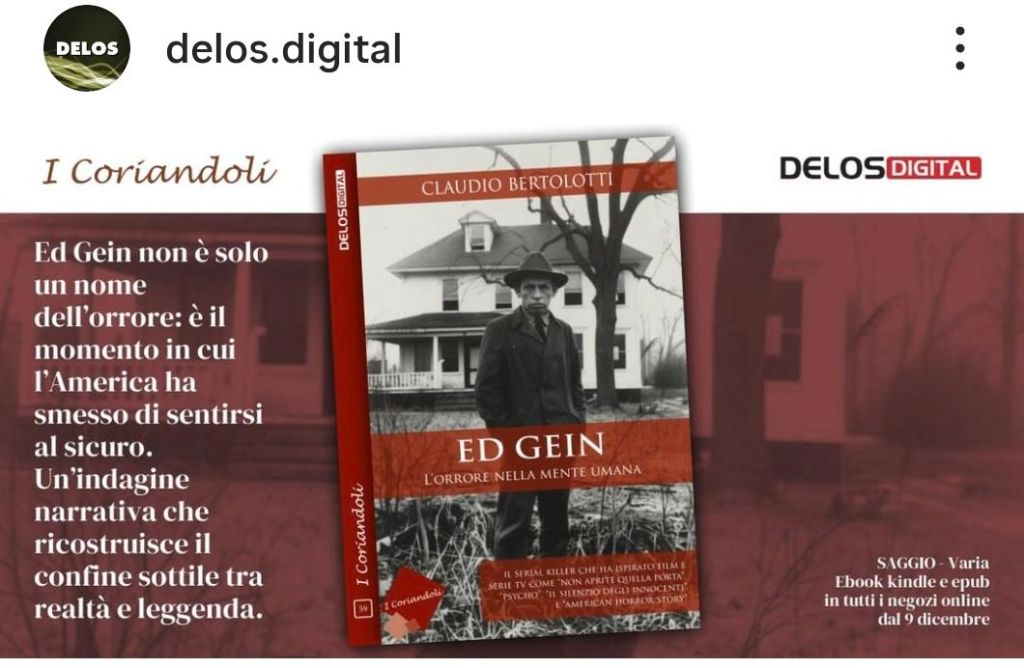Ogni volta che avviene un crimine grave, accade qualcosa di prevedibile:
cerchiamo ordine.
Non solo giustizia.
Non solo responsabilità.
Cerchiamo una struttura che rimetta il mondo al suo posto.
Perché il crimine, soprattutto quello inspiegabile, fa saltare l’equilibrio simbolico su cui poggia la nostra idea di normalità.
Il crimine come frattura
Un crimine violento non è solo un fatto.
È una rottura.
Rottura della fiducia.
Rottura delle regole implicite.
Rottura dell’idea che il mondo sia, in fondo, prevedibile.
Il bisogno di ordine nasce da qui.
Dalla necessità di riparare quella frattura il più rapidamente possibile.
La spiegazione come consolazione
La prima forma di ordine è la spiegazione.
Vogliamo sapere:
perché è successo
chi è stato
cosa lo ha causato
Non perché la curiosità sia morbosa,
ma perché una causa chiara ristabilisce una sensazione di controllo.
Se il crimine ha una causa,
allora può essere contenuto.
Se può essere contenuto,
non è ovunque.
Il mito del caso isolato
Una delle strategie più comuni per ristabilire ordine è trasformare il crimine in eccezione.
Un individuo deviato.
Un evento raro.
Un’anomalia imprevedibile.
Il caso isolato è rassicurante.
Non mette in discussione il sistema.
Non chiede revisioni profonde.
Ma spesso l’ordine così ricostruito è solo apparente.
Il rischio dell’ordine troppo rapido
Quando il bisogno di ordine diventa urgente,
si accettano spiegazioni semplici.
Si cerca una narrazione chiusa.
Un colpevole che assorba tutto.
Un movente che non lasci zone grigie.
Ma la complessità non scompare perché viene ignorata.
Un ordine costruito in fretta rischia di essere fragile.
E la fragilità, prima o poi, riemerge.
Il ruolo del racconto
Anche il modo in cui raccontiamo un crimine partecipa a questa ricostruzione dell’ordine.
Il racconto può:
consolare
semplificare
ridurre
oppure può lasciare aperte le domande scomode.
Il true crime analitico non serve a rassicurare.
Serve a mostrare che l’ordine precedente al crimine
forse non era così solido come pensavamo.
Il caso che mette in crisi l’ordine
Il caso di Ed Gein è emblematico in questo senso.
Ridotto spesso a figura grottesca o iconica,
diventa facilmente confinabile in una categoria rassicurante: “mostro”.
Ma un’analisi più attenta mostra qualcosa di più inquietante.
Non un’esplosione improvvisa,
ma una costruzione lenta.
Non un’anomalia isolata,
ma una devianza sedimentata nel silenzio e nell’isolamento.
L’ordine che pensavamo stabile non era stato messo davvero alla prova.
Ordine o comprensione?
Dopo il crimine possiamo scegliere.
Possiamo cercare un ordine immediato,
che chiuda la frattura e permetta di voltare pagina.
Oppure possiamo accettare una comprensione più lenta,
che non ripara subito,
ma illumina le dinamiche profonde.
Il primo rassicura.
Il secondo inquieta.
Ma solo il secondo è utile.
Una responsabilità collettiva
Il bisogno di ordine non è un difetto.
È una reazione umana.
Diventa problematico quando si trasforma in fretta di dimenticare.
Capire il crimine significa accettare che l’ordine precedente
forse conteneva già le condizioni della frattura.
E questo è molto più difficile da sostenere.
Approfondimento
Questo approccio guida il mio lavoro sul true crime:
analizzare non solo l’atto, ma le strutture che lo precedono.
Nel saggio dedicato al caso Ed Gein, il focus non è sull’icona dell’orrore,
ma sulla costruzione lenta di una devianza nel tempo e nel silenzio.
Ed Gein – L’orrore della mente umana
- Ebook Delos Digital: https://share.google/8pIw4FN0LDpZX2FBQ
- Amazon ebook: https://amzn.eu/d/8PChNOH
- Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/ebook/autori/claudio-bertolotti
- IBS: https://share.google/dNuTe1qRjc5rqz1AJ
- HorrorMagazine: https://share.google/EzYtNodTJ9TJ5Dc0C
- Hoepli: https://www.hoepli.it/amp/ed-gein-lorrore-della-mente-umana/9788825435054.html
Contatti ufficiali
🌐 Sito ufficiale
www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram
@autoreclaudiobertolotti
@archivio_blackwood
📘 Facebook personale
https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack
https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram
https://t.me/archivioblackwood
🎵 TikTok
https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8
📺 YouTube
https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM