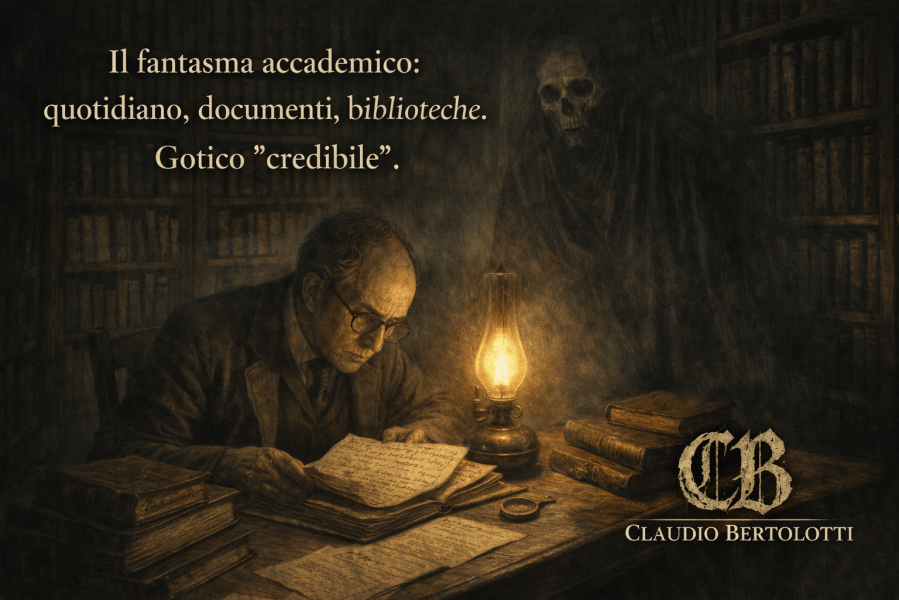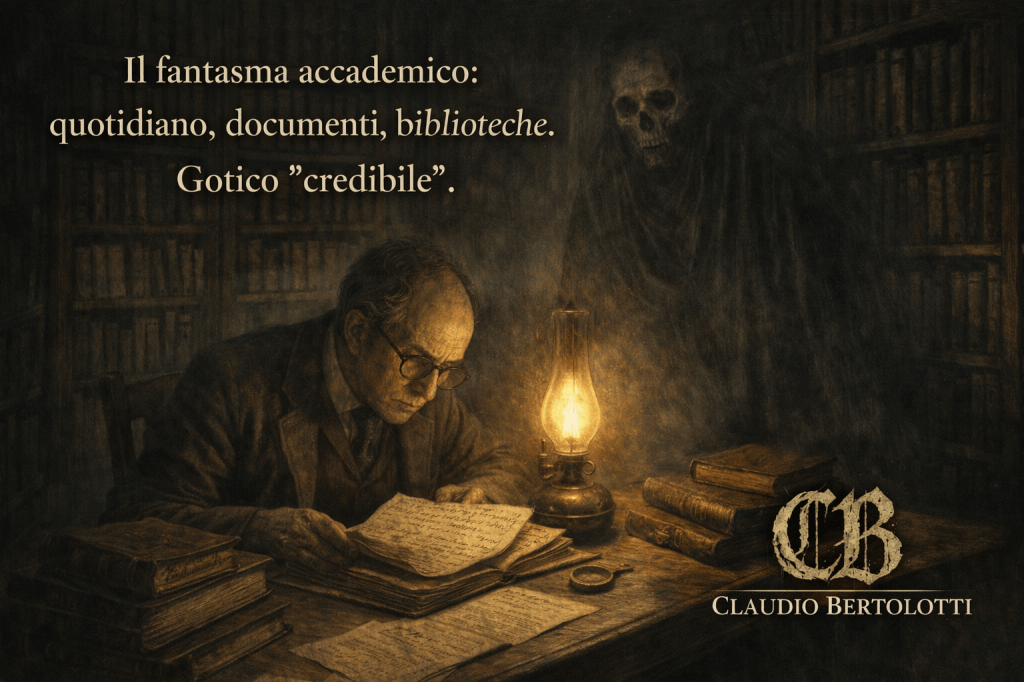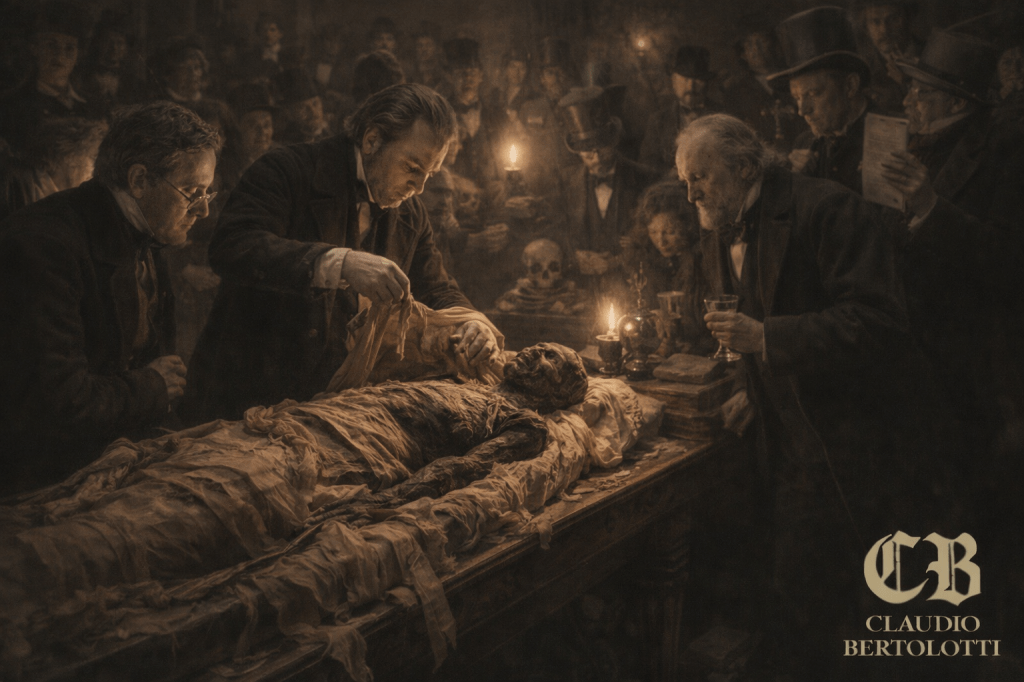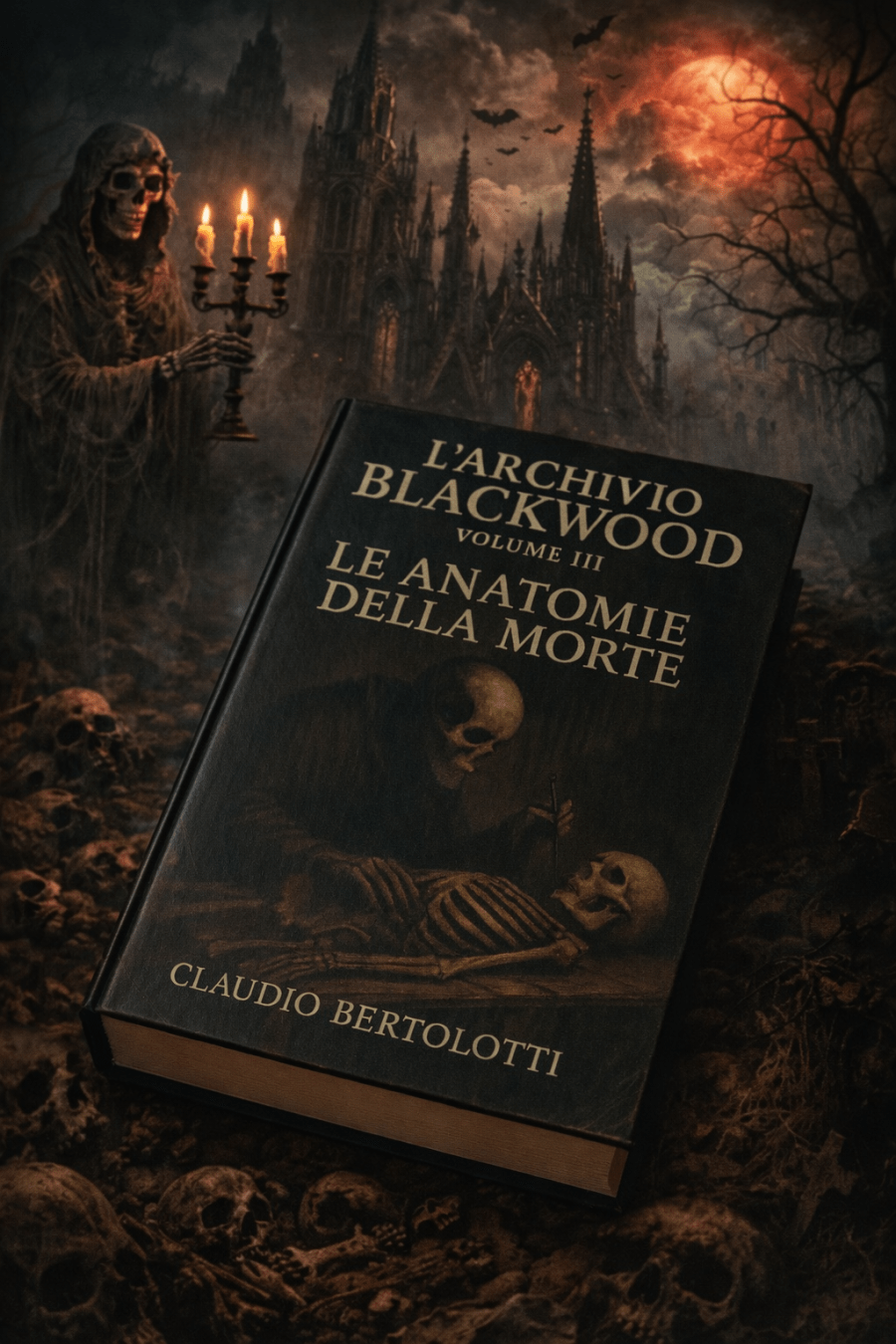Tensione, attesa, sottrazione
C’è un equivoco ricorrente quando si parla di horror: l’idea che l’orrore nasca da ciò che si mostra. Sangue, urla, mostri, violenza esplicita. In realtà, l’horror più efficace funziona spesso al contrario. Non aggiunge: toglie.
Molti dei testi più disturbanti della letteratura e della narrativa contemporanea non sono “horror” in senso stretto. Non insistono sulla paura, non cercano lo shock. Lasciano invece che il lettore arrivi da solo al punto di rottura. È lì che nasce l’inquietudine vera.
La tensione non è l’evento, ma la sua possibilità
La tensione non coincide con ciò che accade, ma con ciò che potrebbe accadere. È uno stato di sospensione. Un’attesa prolungata in cui il lettore percepisce che qualcosa non torna, ma non sa ancora cosa.
In questo tipo di scrittura, l’evento è spesso secondario. A volte non arriva nemmeno. Ciò che conta è la pressione progressiva: piccoli segnali fuori posto, dettagli che non combaciano, ripetizioni lievemente anomale. Il cervello del lettore inizia a lavorare, a cercare una spiegazione, a colmare i vuoti. E proprio lì si genera il disagio.
La tensione nasce quando il testo non rassicura.
L’attesa come spazio narrativo
L’horror più sottile non corre. Rallenta. Si prende il tempo di mostrare il quotidiano, di renderlo riconoscibile, persino banale. È una scelta precisa: più il contesto è normale, più ogni minima deviazione risulta significativa.
L’attesa non è un vuoto narrativo, ma uno spazio pieno di possibilità. Il lettore sente che qualcosa sta per incrinarsi, ma non sa quando né come. Questa incertezza è più potente di qualsiasi rivelazione immediata.
In molte storie disturbanti, il momento più efficace non è la scena finale, ma ciò che la precede: il corridoio percorso più volte, la stanza osservata senza motivo apparente, una frase detta e poi dimenticata. L’attesa diventa una forma di minaccia silenziosa.
La sottrazione come tecnica etica
Sottrarre significa scegliere cosa non dire. Significa fidarsi dell’intelligenza del lettore. Non spiegare tutto, non chiudere ogni interpretazione, non fornire una causa unica e definitiva.
La sottrazione funziona perché lascia aperte le domande. E le domande irrisolte sono ciò che resta dopo la lettura. Un testo che spiega troppo si consuma in fretta. Un testo che trattiene continua a lavorare nella mente di chi legge.
Scrivere horror senza essere horror vuol dire spesso rinunciare all’effetto immediato per ottenere una risonanza più lunga. Non è una scelta di stile, ma di responsabilità narrativa: decidere che l’orrore non va imposto, ma suggerito.
Quando il male non ha bisogno di mostrarsi
Il male più disturbante è quello che non ha una forma chiara. Non è identificabile, non è facilmente isolabile. Vive negli interstizi: nelle abitudini, nelle istituzioni, nei silenzi, nei gesti ripetuti.
In questa prospettiva, l’horror non è un genere, ma un effetto collaterale. Nasce quando il lettore si accorge che ciò che sta leggendo potrebbe esistere. O peggio: che in parte esiste già.
Ed è proprio allora che il testo smette di essere “horror” e diventa qualcosa di più difficile da scrollarsi di dosso.
Contatti ufficiali
🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood
📘 Facebook personale: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8
📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM