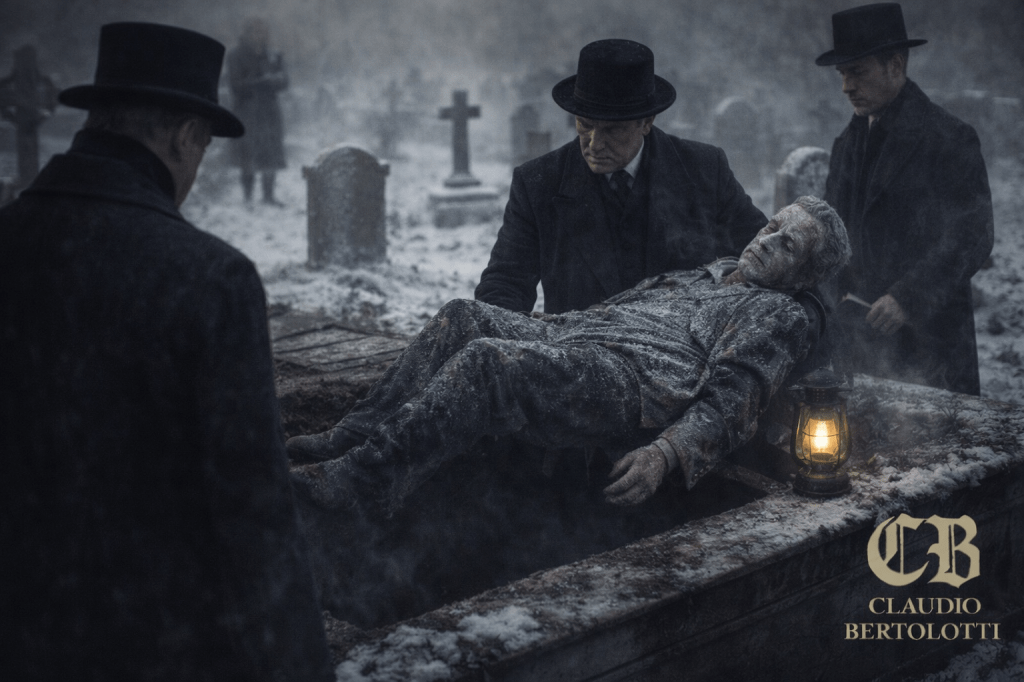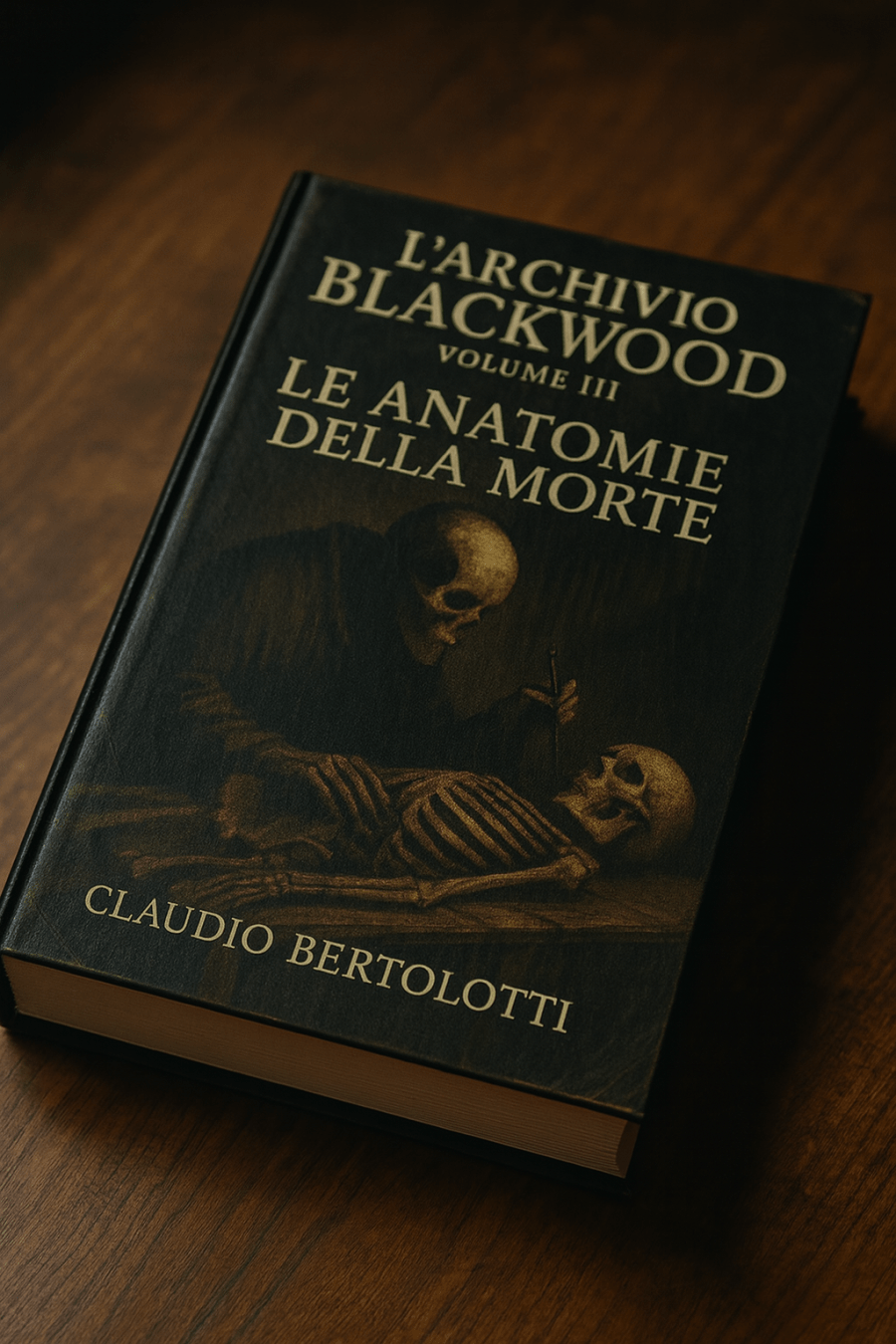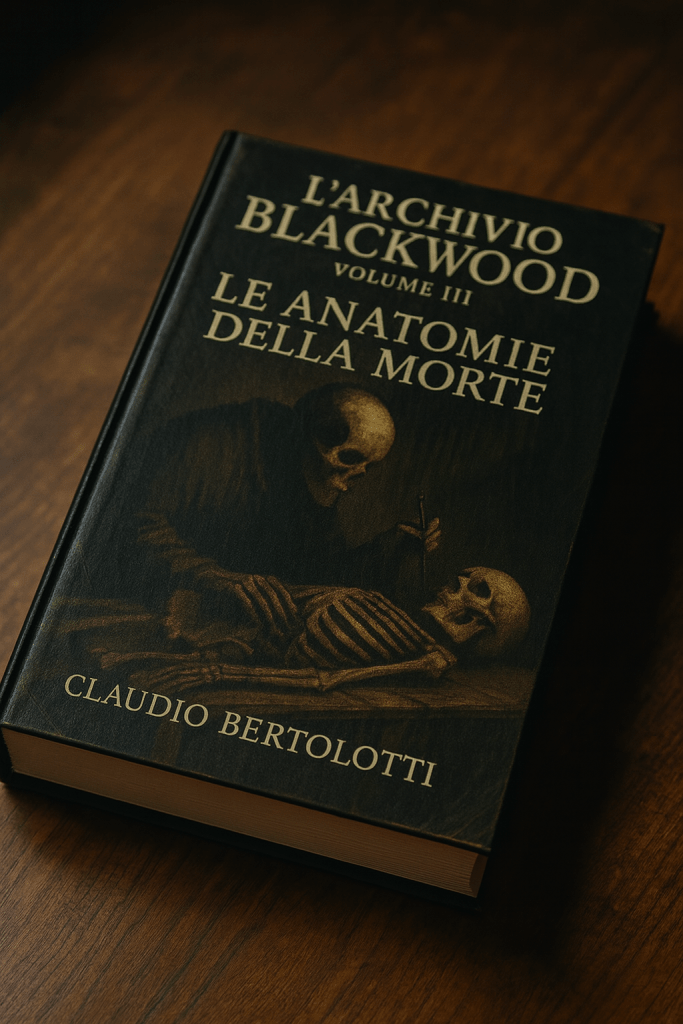In ogni casa esiste una stanza dove nessuno entra mai.
Non è chiusa a chiave. Non è proibita. Non è pericolosa, almeno in apparenza.
È semplicemente lì.
La porta resta accostata. Non spalancata, non chiusa. Quel tanto che basta per suggerire che non sia il caso. Dentro, l’aria è più ferma. Non fredda: immobile. Come se il tempo avesse deciso di rallentare proprio lì, di accumularsi negli angoli, negli oggetti che non servono più ma non vengono mai buttati.
Nessuno ricorda esattamente cosa ci sia dentro.
Eppure tutti lo sanno.
Una sedia che non si usa.
Un armadio che non si apre.
Una scatola che non si sposta.
La stanza non fa nulla. Non chiama, non minaccia. Aspetta.
E questa è la cosa peggiore.
Quando qualcuno passa davanti a quella porta, abbassa la voce senza accorgersene.
Quando la casa è silenziosa, il silenzio sembra arrivare da lì.
Non è una stanza dell’orrore.
È una stanza dell’assenza.
Analisi: perché quella stanza funziona così bene
La stanza dove nessuno entra mai è uno degli strumenti narrativi più potenti dell’horror e del gotico, proprio perché non agisce.
Non succede niente lì dentro.
Ed è questo che la rende inquietante.
Dal punto di vista psicologico e narrativo, quella stanza rappresenta tre elementi fondamentali:
1. Il non elaborato
È lo spazio del rimosso. Ciò che non si affronta, non si nomina, non si guarda.
In una storia, equivale a un trauma irrisolto, a una colpa mai detta, a un evento che tutti conoscono ma che nessuno commenta.
2. Il tempo congelato
Quella stanza non evolve. È ferma.
Nel racconto, questo crea un contrasto potentissimo con il resto della casa (o della vita): tutto cambia, tranne lì. E il lettore lo percepisce come una minaccia latente.
3. L’illusione del controllo
Finché la porta resta chiusa, i personaggi credono di avere il controllo.
Ma il lettore sa che prima o poi qualcuno entrerà. E quando accadrà, non sarà per curiosità, ma per necessità.
Narrativamente, questa stanza funziona perché non spiega nulla.
Non fornisce informazioni, non chiarisce. Accumula tensione.
È un promemoria silenzioso:
ci sono cose che, se ignorate abbastanza a lungo, non spariscono.
Si limitano ad aspettare.
Perché usarla (e perché non abusarne)
La stanza dove nessuno entra mai non va riempita di spiegazioni.
Va lasciata vuota, o quasi.
Ogni dettaglio in più indebolisce l’effetto.
Ogni spiegazione anticipata toglie potere al silenzio.
È uno spazio narrativo che funziona solo se il lettore immagina più di quanto gli venga mostrato.
Ed è proprio per questo che resta impressa.
Contatti ufficiali
🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood
📘 Facebook personale: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood
🎥 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8