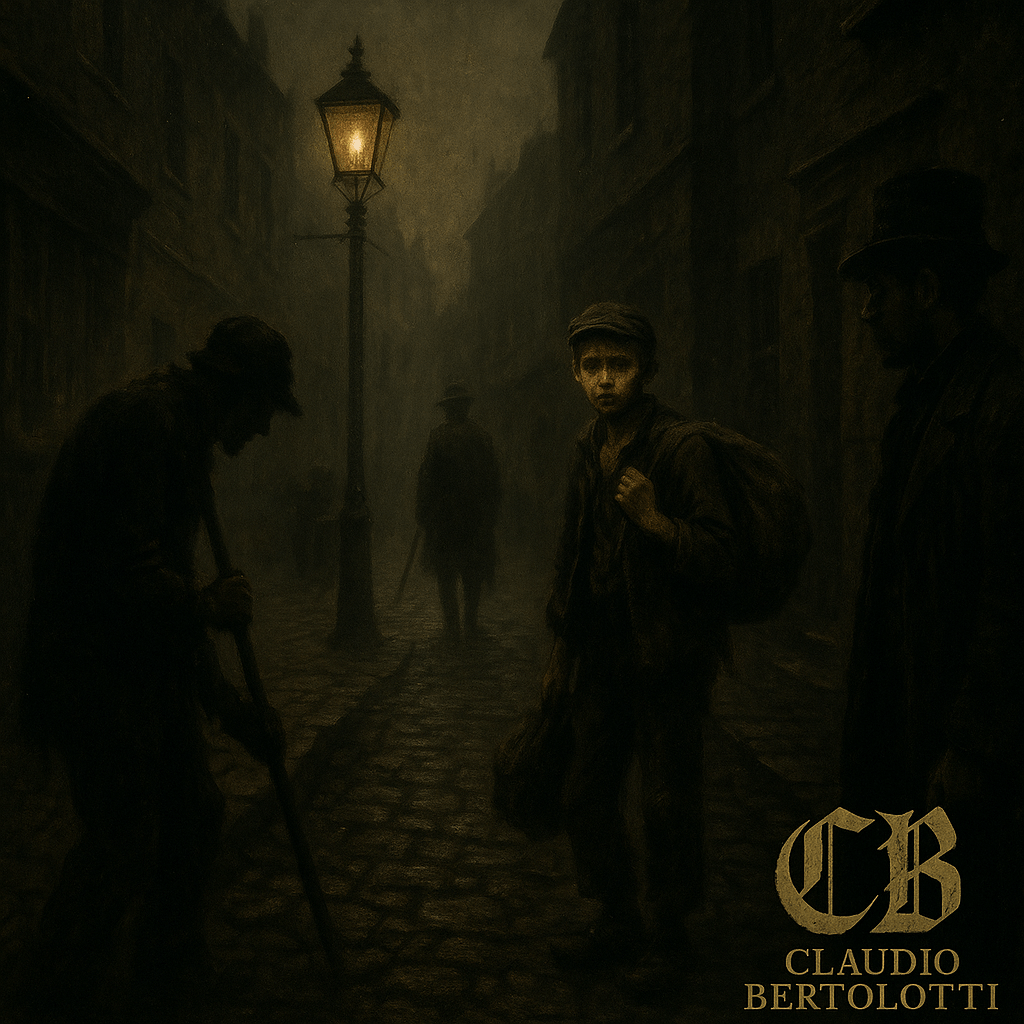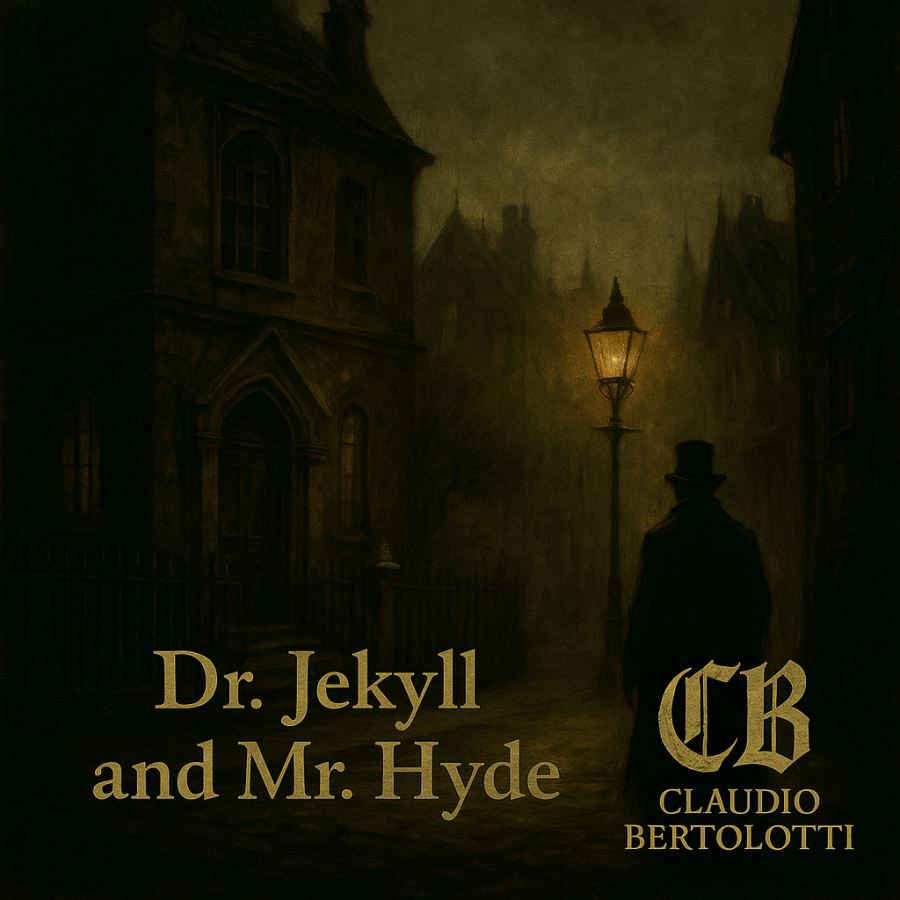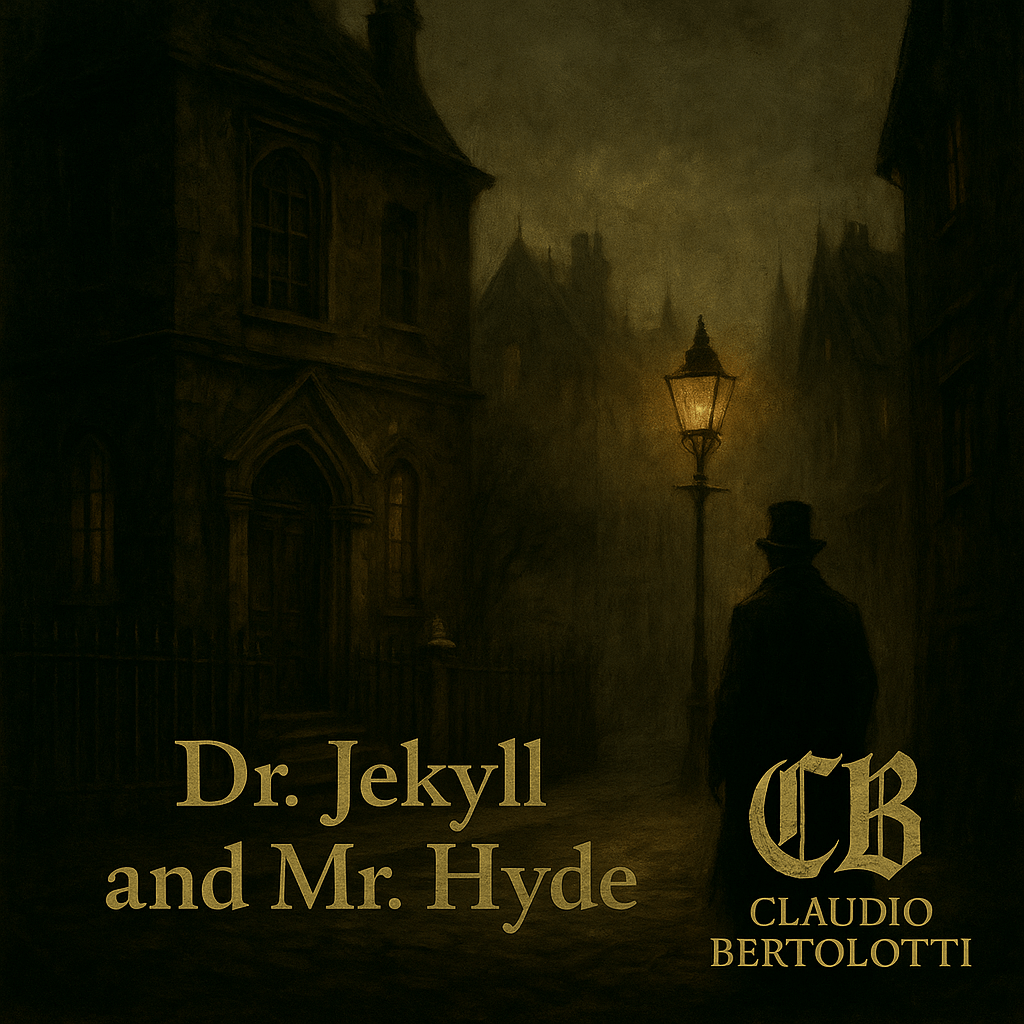Nel racconto del Male esiste un errore ricorrente: pensare che il lettore debba essere guidato, rassicurato, accompagnato per mano fino a una conclusione morale chiara.
Colpevole. Innocente. Spiegato. Archiviato.
Ma il Male reale non funziona così.
E chi legge non dovrebbe essere messo nella posizione del giudice, bensì in quella – molto più scomoda – del testimone.
Il giudice osserva dall’alto.
Il testimone è dentro la stanza.
Quando leggiamo un caso di cronaca nera, un saggio narrativo, una storia che affonda le mani nella mente umana, non stiamo partecipando a un processo. Stiamo assistendo a qualcosa che è già accaduto. Non possiamo cambiarlo, né correggerlo. Possiamo solo guardarlo senza distogliere lo sguardo.
Ed è qui che la letteratura smette di essere intrattenimento.
Il lettore-testimone non cerca assoluzioni.
Non pretende spiegazioni che mettano ordine.
Non chiede un colpevole da odiare per sentirsi al sicuro.
Accetta, invece, una verità più scomoda: che il Male non è sempre riconoscibile, che non nasce dal nulla, che spesso cresce lentamente, in silenzio, dentro contesti apparentemente normali. Famiglie. Case. Abitudini. Religioni. Solitudini.
Rendere il lettore un giudice significa offrirgli distanza.
Renderlo un testimone significa offrirgli responsabilità.
Responsabilità di capire senza giustificare.
Di osservare senza indulgere.
Di ricordare senza trasformare l’orrore in spettacolo.
Il testimone non applaude.
Non commenta con leggerezza.
Non esce dalla storia pulito.
Esce cambiato.
Per questo scrivere il Male non significa insegnare una lezione, ma costruire uno spazio di osservazione. Un luogo narrativo dove il lettore è costretto a restare, a respirare la stessa aria stantia, a sentire il peso delle domande senza risposta.
Il giudizio consola.
La testimonianza no.
E forse, oggi più che mai, abbiamo bisogno di lettori che non cerchino conforto, ma consapevolezza. Lettori disposti a guardare l’abisso non per dominarlo, ma per riconoscerlo quando si presenta con il volto della normalità.
Perché il Male non chiede di essere spiegato.
Chiede di essere visto.
Contatti e canali ufficiali
🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood
📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8
📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM