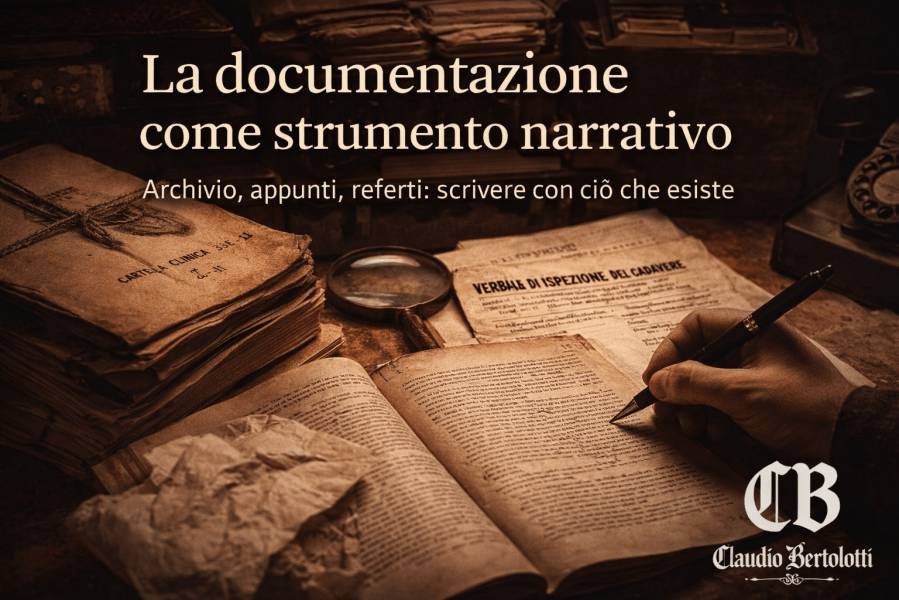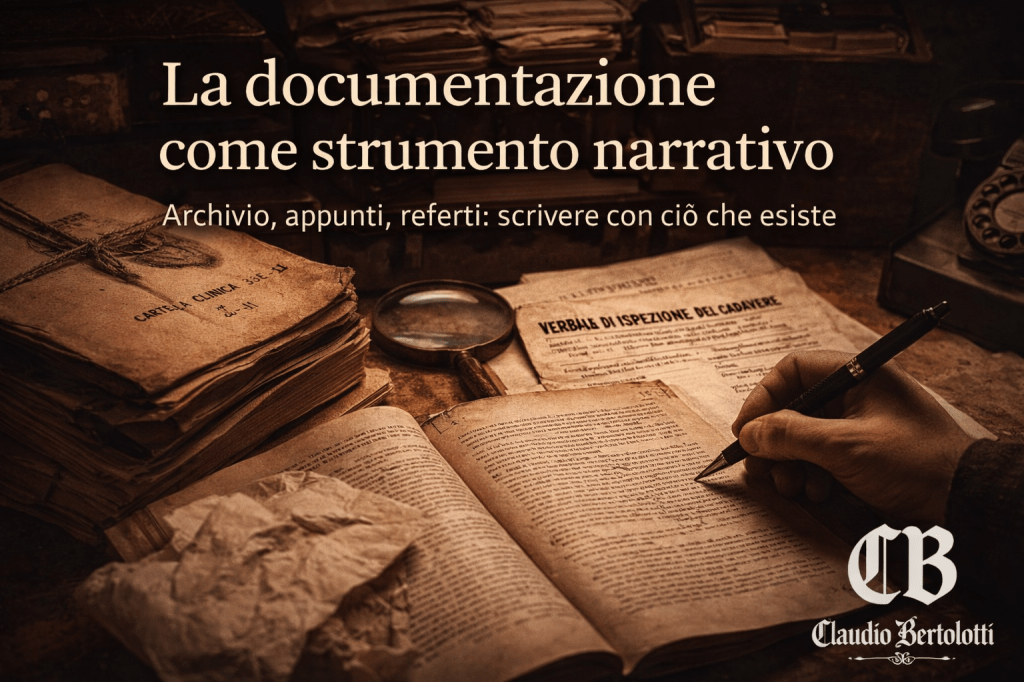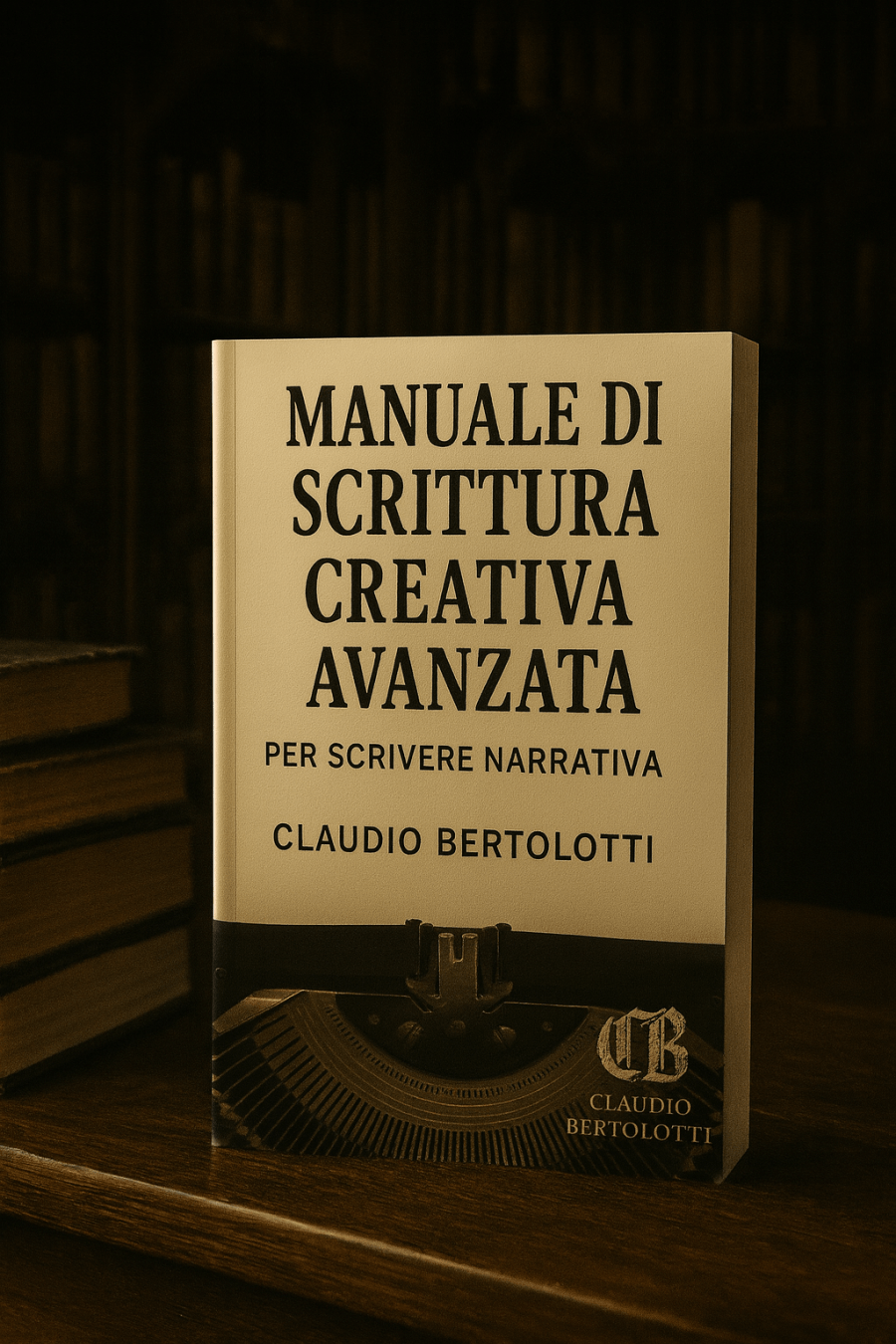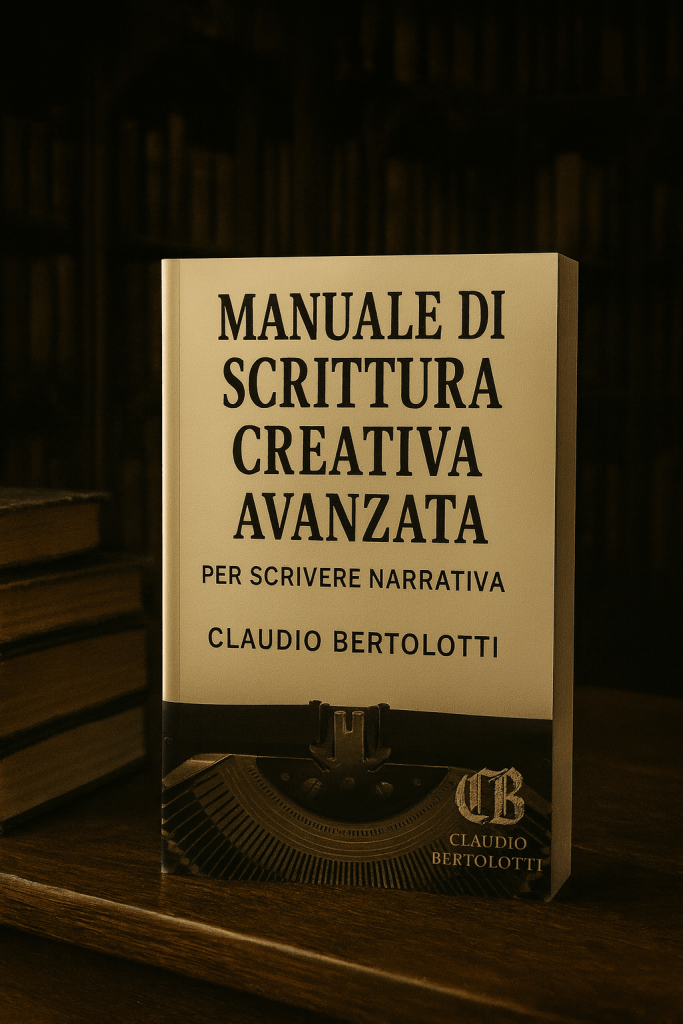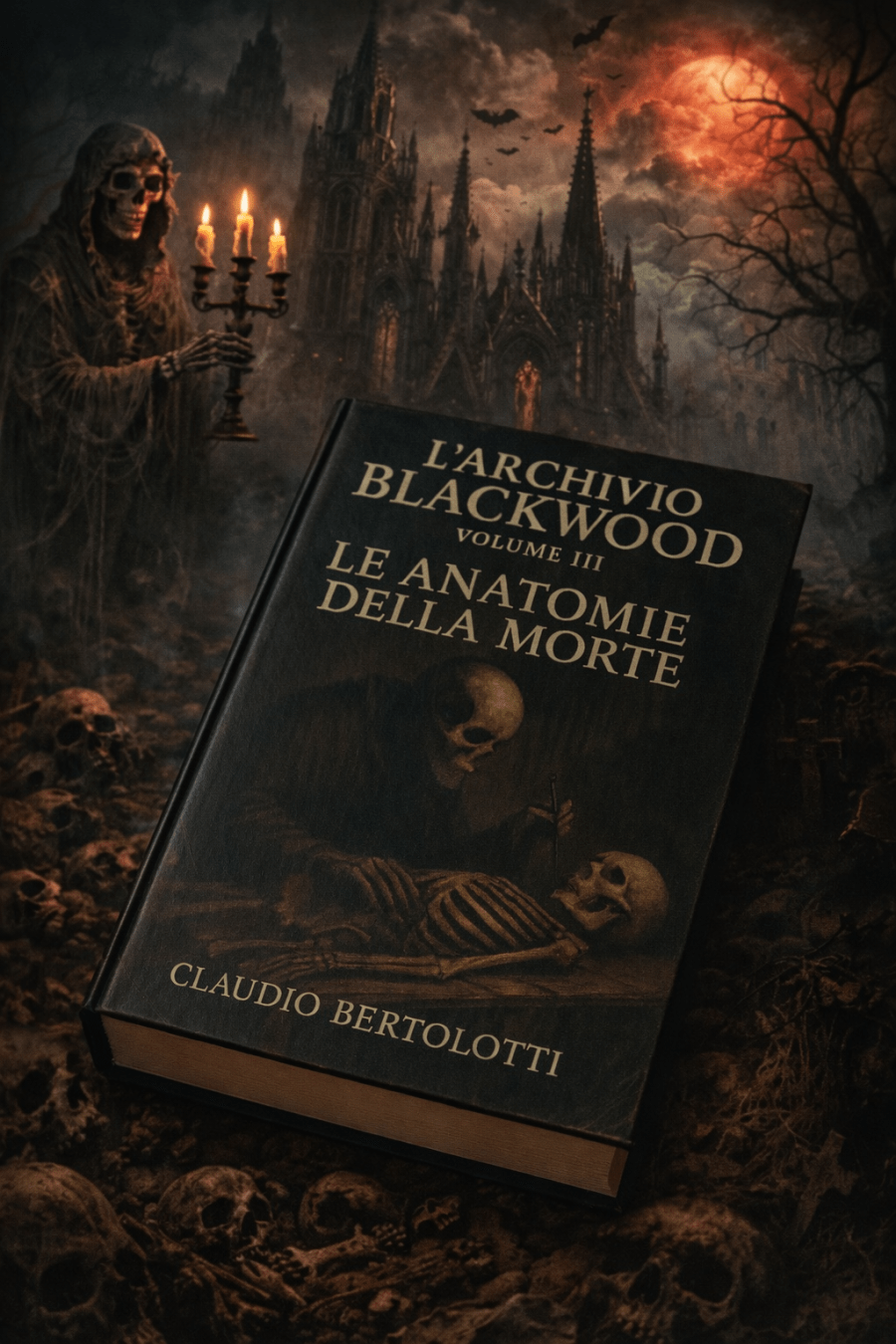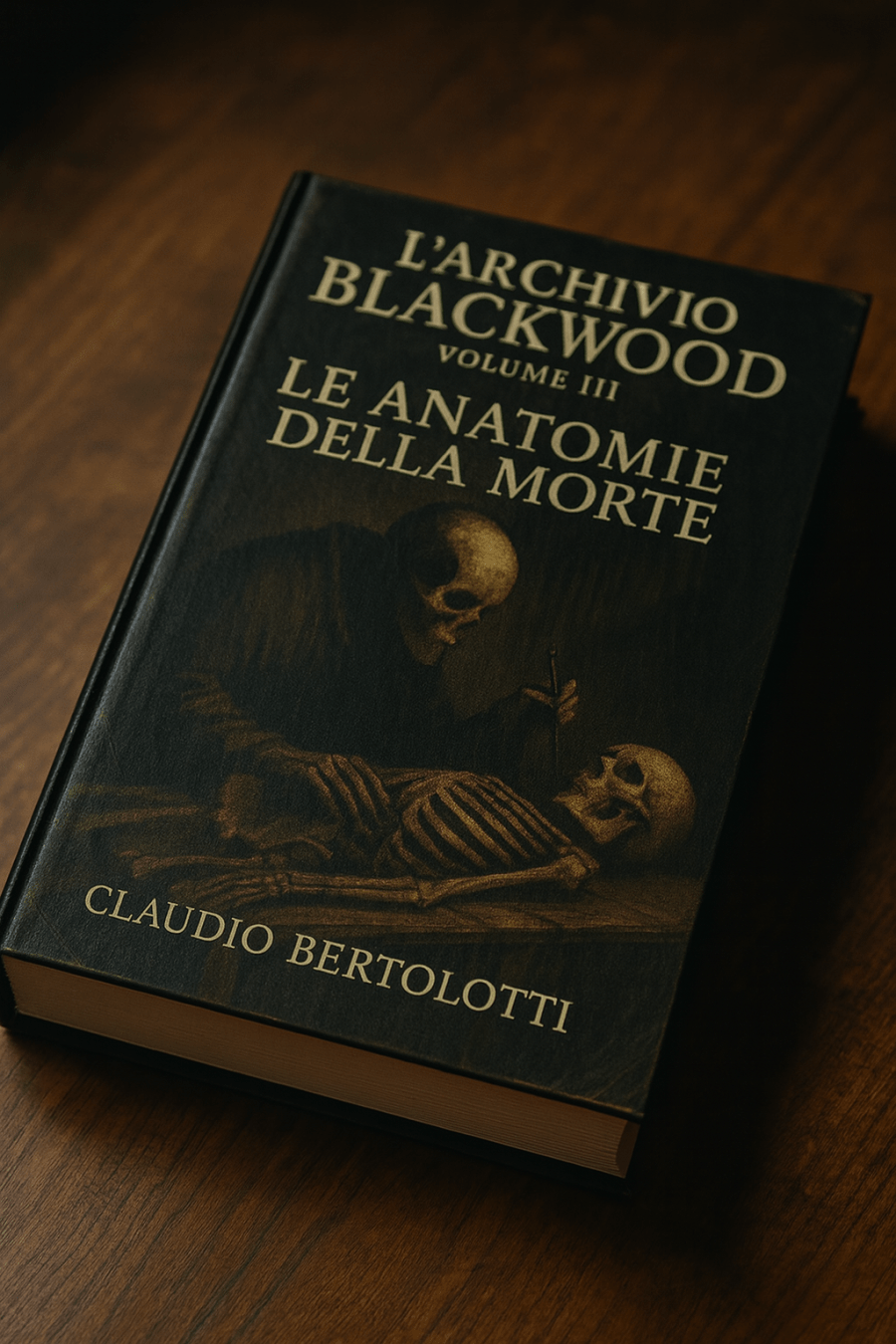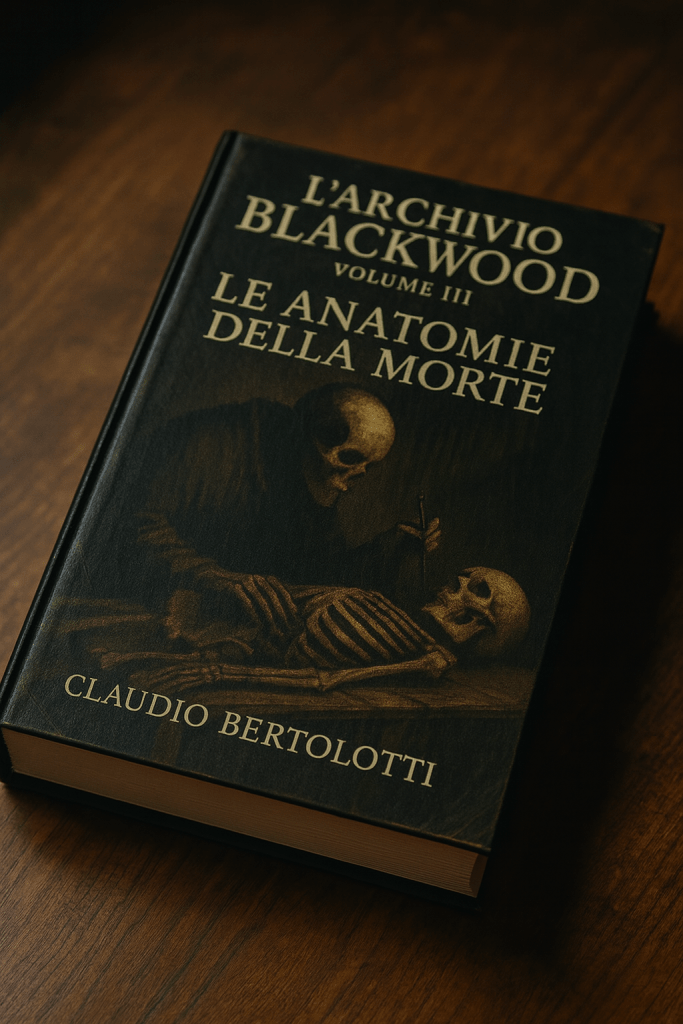Di Barbara Baraldi
L’idea di partenza promette molto: un’indagine che intreccia razionalità investigativa ed esoterismo, un legame familiare spezzato, una città silenziosa come Trieste trasformata in teatro di paura. Sulla carta, Gli omicidi dei tarocchi sembra voler costruire un giallo suggestivo e stratificato. Nella resa finale, però, il risultato appare debole e incompiuto.
La struttura a capitoli brevissimi — due, tre pagine al massimo — dà al romanzo un ritmo che ricorda più una lettura pensata per un pubblico molto giovane che un thriller adulto. Questo spezzettamento continuo non crea tensione, ma al contrario appiattisce l’andamento narrativo e impedisce una vera immersione emotiva.
La trama, pur partendo da uno spunto interessante, si sviluppa in modo prevedibile. Già poco prima della metà del libro è facile intuire la direzione della storia e l’esito finale, con la conseguente perdita di suspense. Il mistero non cresce: si limita a procedere in linea retta, senza reali deviazioni o colpi di scena capaci di sorprendere.
Il personaggio della commissaria Emma Bellini, che dovrebbe essere il fulcro emotivo e narrativo del romanzo, non ha un arco realmente compiuto. Le sue motivazioni restano abbozzate, il conflitto interiore non viene mai davvero approfondito, e il rapporto con la sorella Maia — potenzialmente il cuore del libro — rimane più dichiarato che mostrato.
Dal punto di vista stilistico, la scrittura è corretta ma piatta. Prevale una narrazione esplicativa, con scarso uso dello show, don’t tell: molte emozioni vengono raccontate anziché fatte vivere al lettore. Il ritmo resta costante dall’inizio alla fine, senza picchi, senza accelerazioni né rallentamenti significativi. I cambi di punto di vista sono chiari e non creano confusione, ma nemmeno aggiungono profondità o tensione.
In sintesi, l’idea di fondo è valida e avrebbe potuto dare vita a un romanzo solido e disturbante. Ciò che manca è la costruzione: più coraggio narrativo, più atmosfera, più conflitto e un lavoro più incisivo sui personaggi. Gli omicidi dei tarocchi resta così un’occasione mancata: un libro che poteva essere molto di più, ma che si accontenta di restare in superficie.