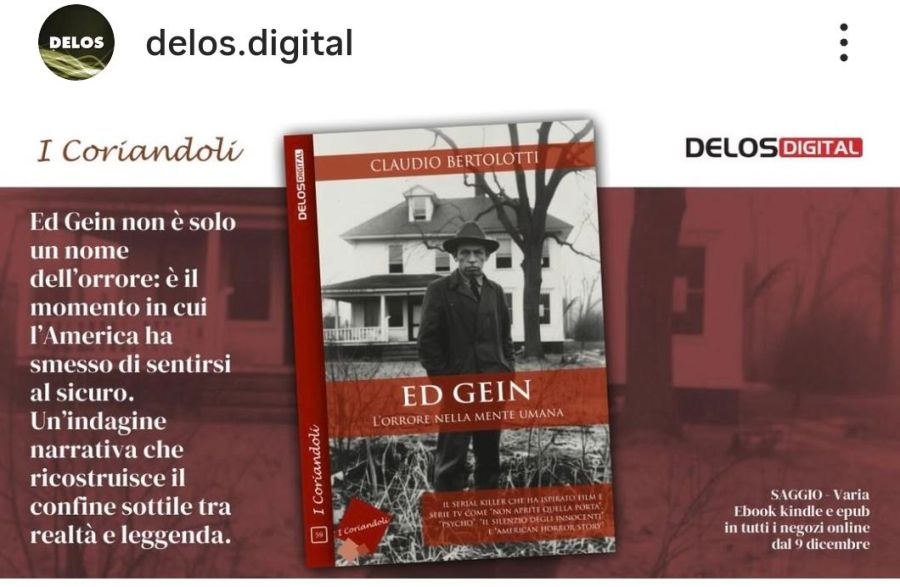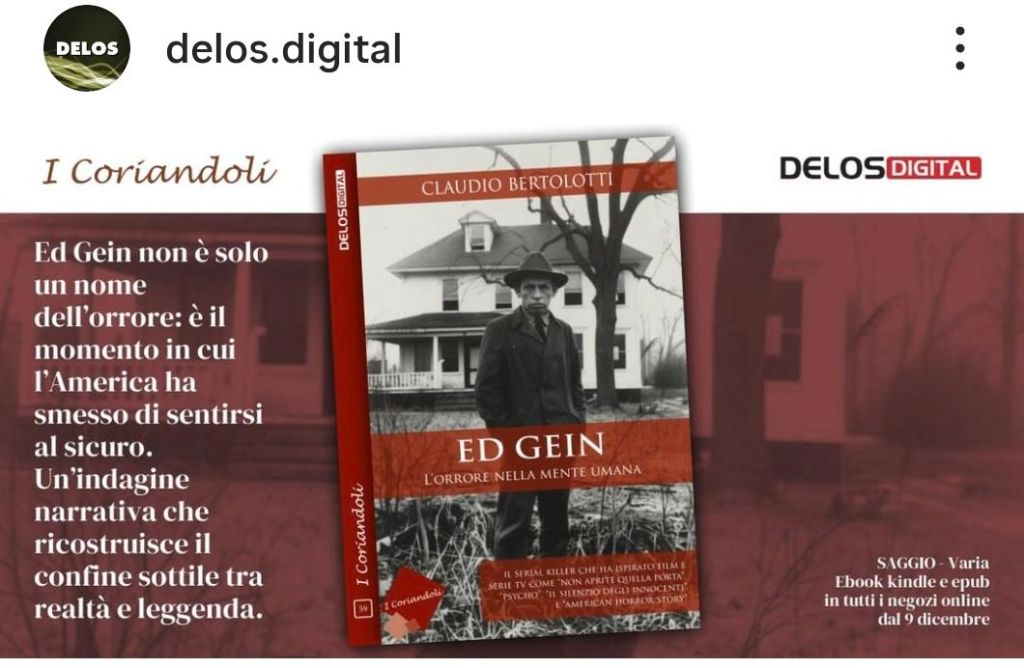(e non tutto ciò che viene raccontato aiuta a capire)
Nel true crime esiste un equivoco di fondo:
che raccontare tutto significhi capire di più.
Non è così.
La verità non è una quantità.
È una relazione.
Ci sono dettagli veri che non chiariscono nulla.
E omissioni consapevoli che spiegano molto di più.
Il problema non è la censura.
È la responsabilità dello sguardo.
Il mito dell’accumulo
Oggi il true crime funziona per accumulo:
più fatti
più immagini
più ricostruzioni
più dettagli disturbanti
L’idea implicita è che la comprensione nasca dalla saturazione.
Ma la mente umana non funziona così.
Satura non significa lucida.
Satura significa anestetizzata.
Quando tutto è mostrato, nulla viene davvero visto.
Capire non è guardare: è scegliere cosa guardare
Ogni racconto è una scelta.
Anche quando finge di essere neutro.
Scegliere di mostrare tutto equivale spesso a non scegliere nulla.
E la non-scelta è la forma più comoda di irresponsabilità narrativa.
Capire un fenomeno umano richiede l’opposto:
sottrazione
gerarchia
attenzione al contesto
attenzione a ciò che manca
Il male non si spiega con ciò che appare,
ma con ciò che non ha mai trovato spazio per esistere diversamente.
Il dettaglio come alibi
Il dettaglio disturbante ha una funzione precisa:
spostare lo sguardo.
Finché guardiamo cosa è stato fatto,
non dobbiamo chiederci perché quel mondo lo ha reso possibile.
Il dettaglio diventa un alibi cognitivo:
ci permette di dire “è troppo”,
senza dire “è comprensibile”.
Comprensibile non nel senso morale.
Nel senso strutturale.
Quando il racconto diventa una forma di consumo
Un racconto che non lascia residuo,
che non inquieta dopo,
che non genera domande scomode,
non è un’indagine.
È un prodotto.
Il consumo del male ha una caratteristica precisa:
finisce esattamente dove inizia.
L’analisi, invece, continua a lavorare nel lettore.
A volte per giorni.
A volte per anni.
Perché questo riguarda anche la narrativa
Questa distinzione non vale solo per il true crime.
Vale per il gotico.
Per l’horror psicologico.
Per ogni forma di scrittura che affronta il lato oscuro dell’umano.
Mostrare non è scrivere.
Scrivere è decidere cosa non mostrare.
Il silenzio non è un vuoto narrativo.
È uno spazio attivo.
Ed è lì che nasce la vera inquietudine.
Una posizione necessaria
Raccontare il male non significa esaurirlo.
Significa assumersi il rischio di non renderlo comodo.
Un racconto che consola ha fallito.
Un racconto che inquieta ha iniziato a fare il suo lavoro.
Per questo non tutto ciò che è vero deve essere raccontato.
E non tutto ciò che viene raccontato aiuta davvero a capire.
Nota finale
Questo approccio guida sia il mio lavoro saggistico sul true crime
sia la mia narrativa gotica e investigativa.
Non per sottrarre,
ma per restituire complessità.
Contatti ufficiali
🌐 Sito ufficiale
www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram
@autoreclaudiobertolotti
@archivio_blackwood
📘 Facebook personale
https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack – Archivio Blackwood
https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram
https://t.me/archivioblackwood
🎵 TikTok
https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8
📺 YouTube
https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM