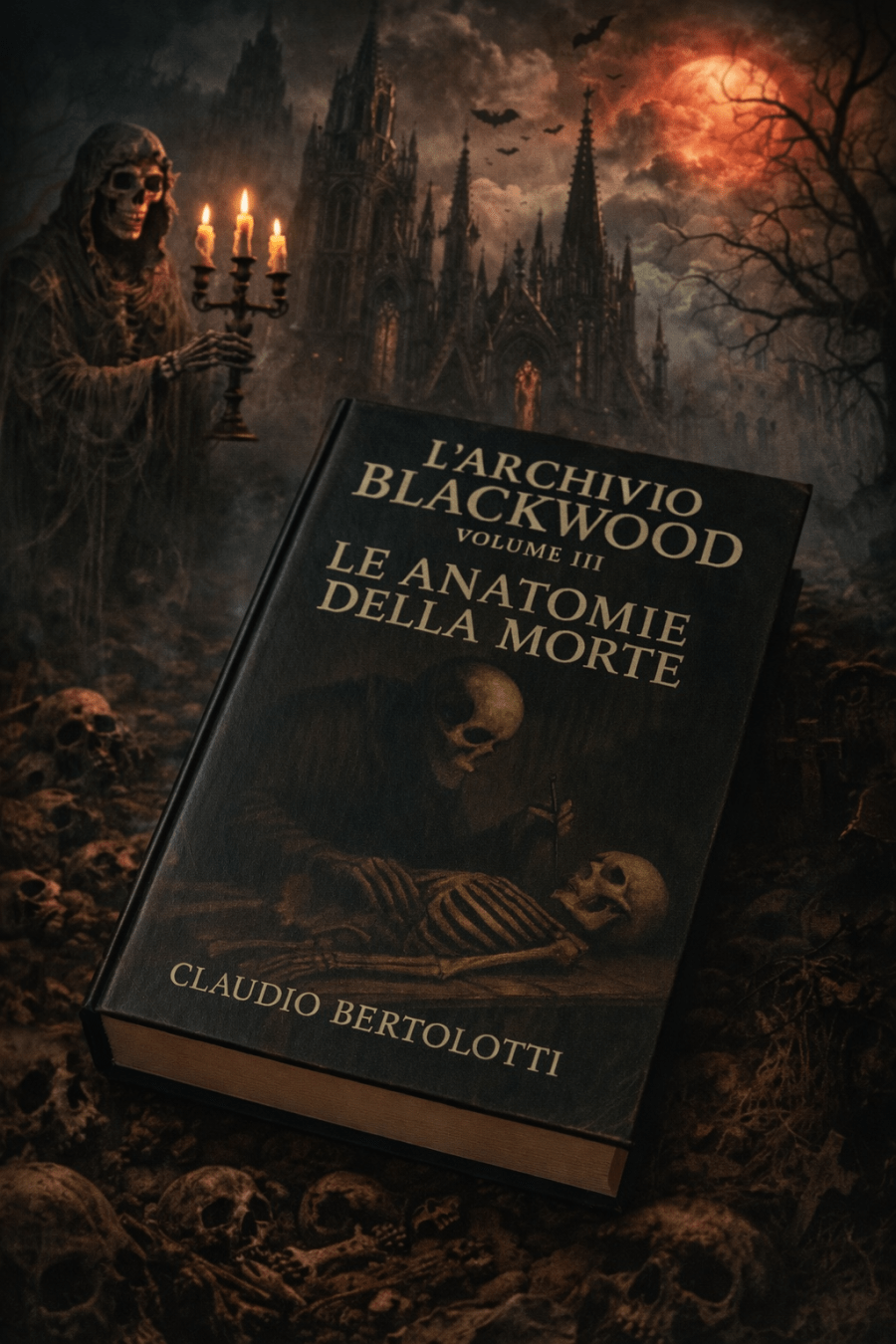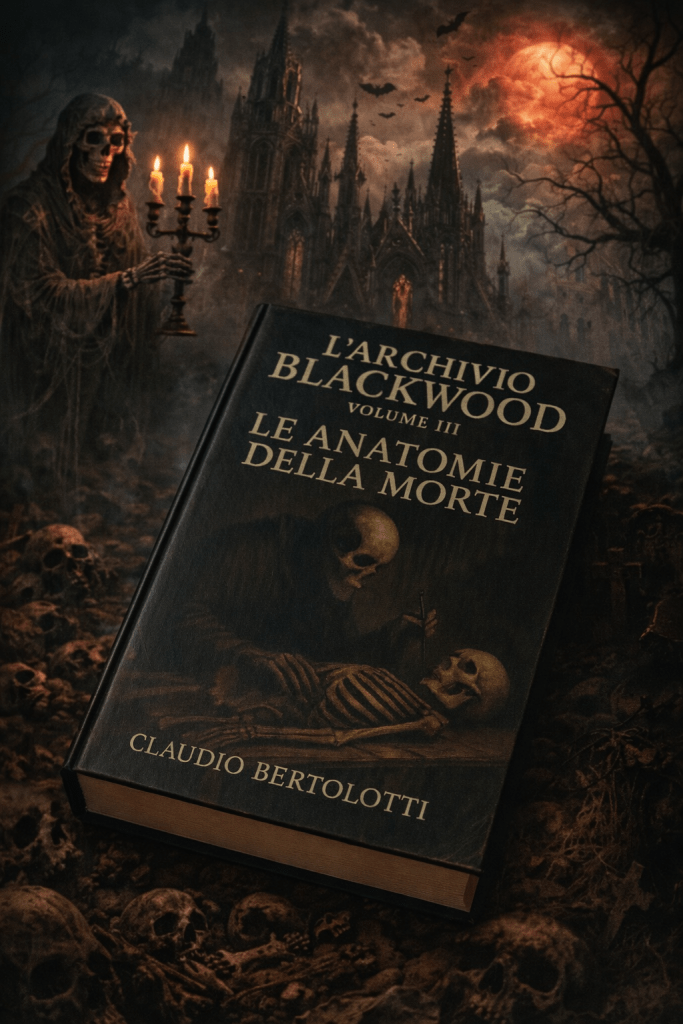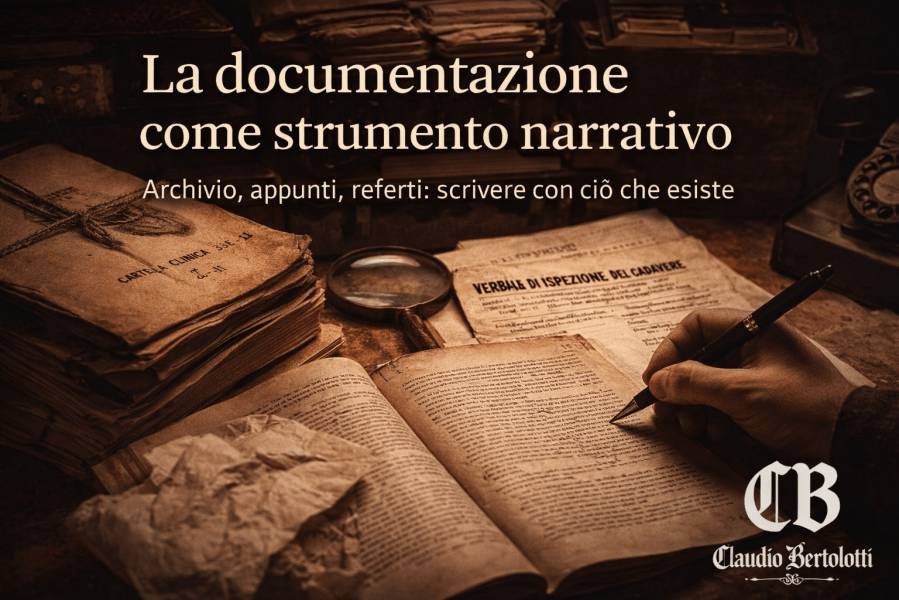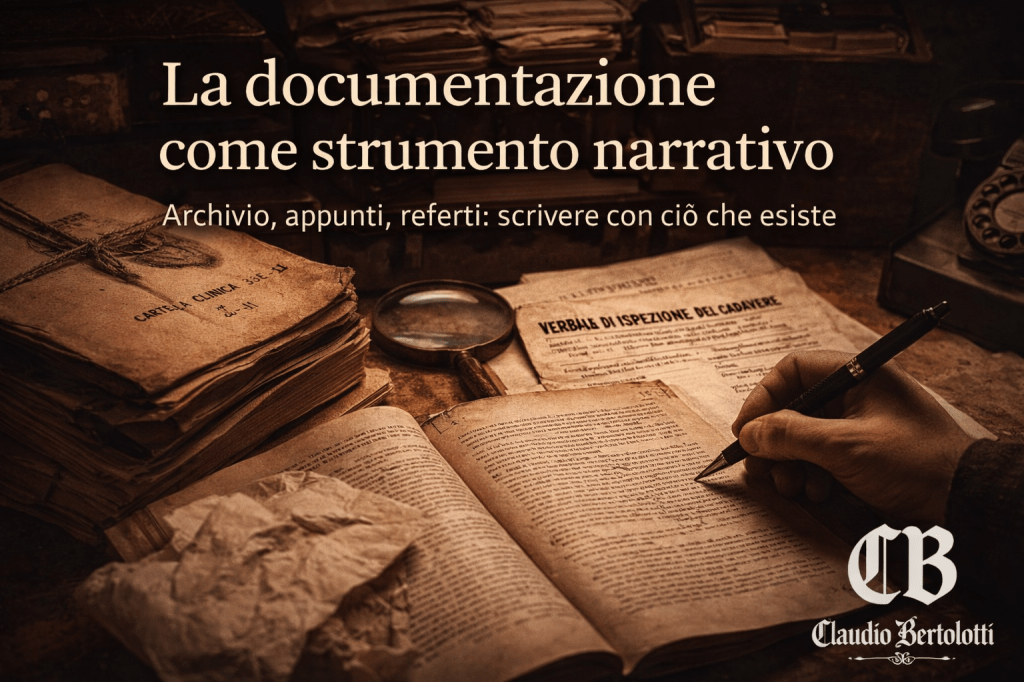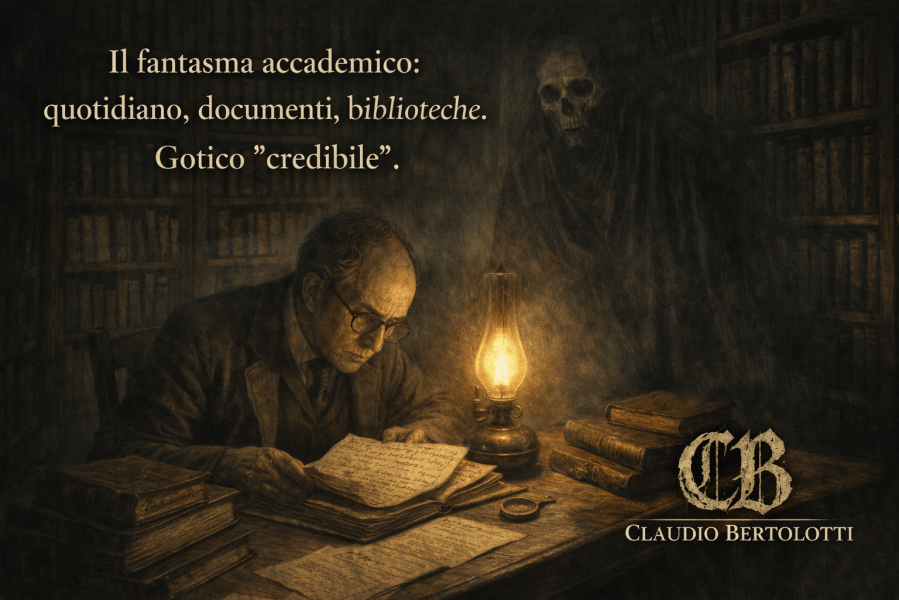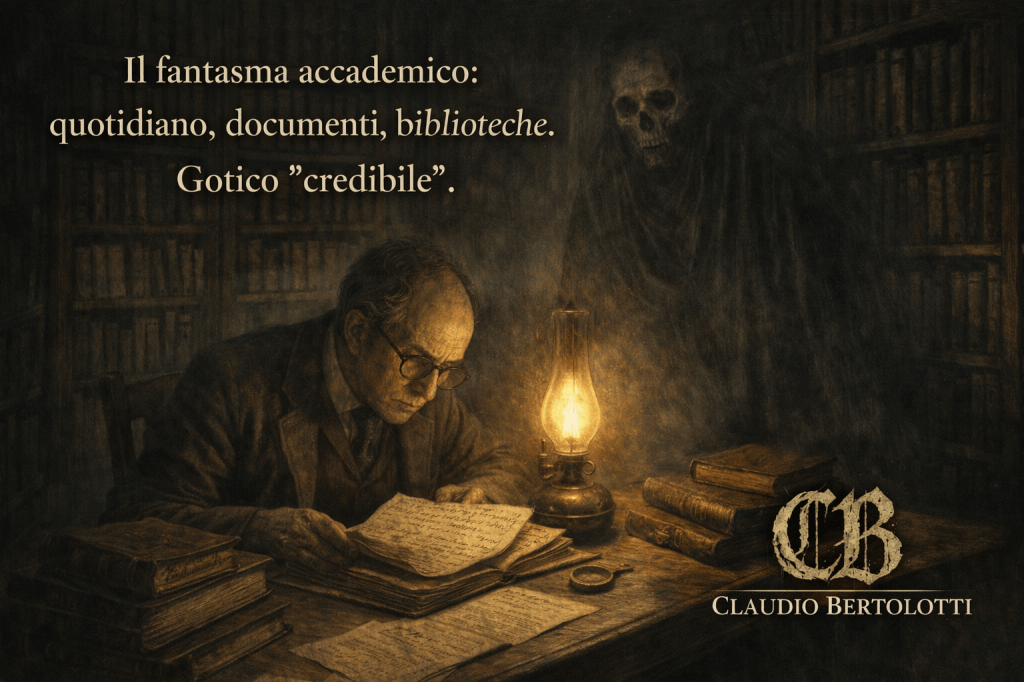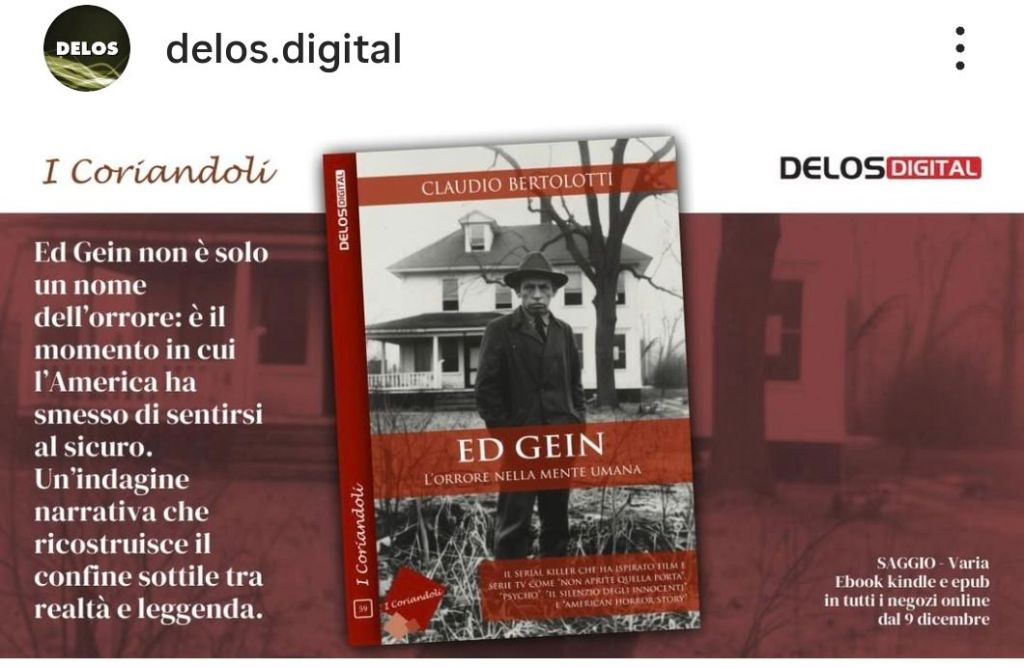Studiare Ed Gein non significa studiare un “mostro”.
Questa è la prima, fondamentale lezione.
La narrazione comune lo ha trasformato in una caricatura dell’orrore: il folle isolato, l’uomo dei feticci, il nome da evocare per disturbare. Ma quando si entra davvero nella sua storia, nei documenti, nei verbali, nei resoconti psichiatrici e nelle testimonianze, ci si accorge che la realtà è molto più inquietante proprio perché è meno spettacolare.
Ed Gein non uccide per odio.
Non agisce per impulso.
Non è dominato dalla rabbia.
Ed Gein costruisce.
La devianza come rifugio, non come esplosione
Uno degli errori più comuni è leggere i suoi crimini come atti di violenza pura. In realtà, ciò che emerge è un bisogno patologico di ricostruzione affettiva.
Gein non distrugge: tenta di ricomporre.
Non elimina l’altro: lo conserva.
Non cerca il caos: crea un ordine tutto suo.
Il suo mondo interiore è fragile, impoverito, immobile nel tempo. La morte non è il fine, ma uno strumento per fermare ciò che teme di perdere: la presenza, la madre, l’identità. È una devianza che nasce dal vuoto, non dall’eccesso.
Ed è questo che la rende difficile da comprendere… e da accettare.
Il vero orrore non è il gesto, ma la logica
Analizzando Gein, ho imparato che il vero orrore non sta nei dettagli macabri – quelli attirano l’attenzione, ma spiegano poco – bensì nella coerenza interna del suo pensiero.
Tutto ciò che fa segue una logica distorta ma stabile.
Nulla è casuale.
Nulla è improvvisato.
Questo è un punto che spesso il true crime moderno evita, perché mette a disagio: se c’è una logica, non possiamo liquidare tutto come follia incomprensibile. E se possiamo comprenderla, allora dobbiamo fare i conti con il fatto che il male non è sempre urlato, caotico, riconoscibile.
A volte è silenzioso.
Domestico.
Persistente.
La semplificazione è una forma di difesa
Trasformare Ed Gein in un’icona horror serve a proteggerci.
Serve a dire: “Lui è altro da noi”.
Ma studiandolo a fondo, emerge una verità scomoda: la sua mente è il risultato di isolamento, dipendenza affettiva, repressione e mancata elaborazione del lutto. Elementi estremi, certo. Ma non alieni.
Questo non giustifica.
Spiega.
Ed è proprio la spiegazione che spesso viene evitata, perché costringe a guardare oltre il racconto facile.
Cosa mi ha lasciato davvero questo studio
Studiare Ed Gein mi ha insegnato che:
- non tutti i serial killer cercano potere o vendetta
- la devianza può nascere dal bisogno di appartenenza
- il confine tra normalità e patologia è più sottile di quanto ci piaccia credere
- raccontare il male senza comprenderlo è solo intrattenimento
Per questo ho scelto di raccontare la sua storia senza indulgenza, ma anche senza compiacimento. Perché capire non significa assolvere, ma evitare che l’orrore venga ridotto a spettacolo.
ED GEIN – L’ORRORE DELLA MENTE UMANA
• Ebook Delos Digital: https://share.google/8pIw4FN0LDpZX2FBQ
• Amazon ebook: https://amzn.eu/d/8PChNOH
• Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/ebook/autori/claudio-bertolotti
• IBS: https://share.google/dNuTe1qRjc5rqz1AJ
• HorrorMagazine: https://share.google/EzYtNodTJ9TJ5Dc0C
• Hoepli: https://www.hoepli.it/amp/ed-gein-lorrore-della-mente-umana/9788825435054.html
Contatti ufficiali
🌐 Sito ufficiale: www.claudiobertolotti83.net
📸 Instagram: @autoreclaudiobertolotti – @archivio_blackwood
📘 Facebook: https://www.facebook.com/share/1Czr6gVnaf/
📬 Substack: https://claudiobertolotti.substack.com
📢 Telegram: https://t.me/archivioblackwood
🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@claudio.bertolott8
📺 YouTube: https://youtube.com/@claudiobertolottiauotre?si=WzE25SAC8fm2zBvM